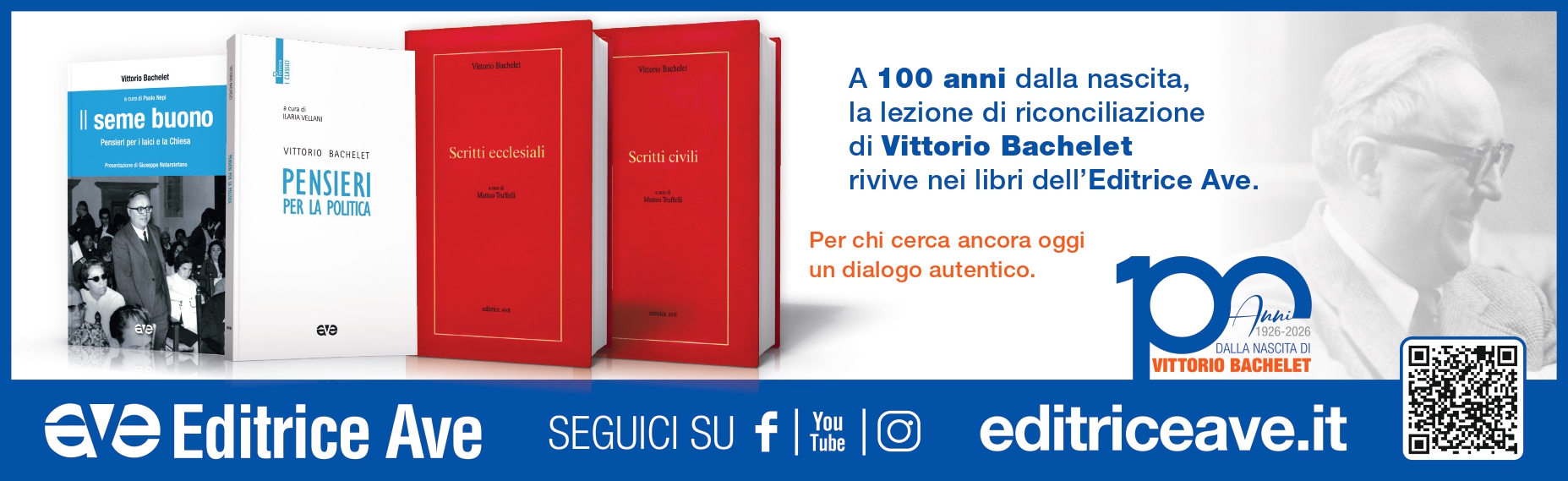I curiosi di questo mondo sanno bene come, a volte, si corra il rischio di ricercare “cosa c’è di nuovo” perdendo l’orizzonte di cosa si va cercando e, soprattutto, della motivazione che spinge alla ricerca (“curioso” ha in sé la radice della cura). Riflettere oggi sull’Iniziazione cristiana richiede di contemplare questo rischio, cercando di contestualizzare quanto emerso dal cammino sinodale per comprendere come, dal punto di vista associativo, mettersi a servizio nella cura dei processi.
L’Iniziazione cristiana (da qui IC, ndr) è dinamica costitutiva della Chiesa, espressione della missione di annunciare il Vangelo, la notizia buona, Gesù Cristo, ad ogni persona. Essa non dice solo cosa fa la comunità (o cosa dovrebbe fare), ma chi è la comunità.
Si traduce infatti dentro un’esperienza che, attraversata, trasforma, un «processo globale attraverso il quale si diventa cristiani» [1], che è generato dentro la relazione e che rigenera il tessuto delle relazioni che rendono la Chiesa il «segno e lo strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano» [2].
Per questo motivo, dentro la fase di conversione ecclesiale che abitiamo, il cammino sinodale ha riaffermato come, alla radice della riflessione sull’IC, debba esserci la comunità, «soggetto protagonista e responsabile dei processi iniziatici» che «genera i suoi figli e rigenera sé stessa» [3].
Quasi a ricordarci – sottovoce – che la rigenerazione della Chiesa è in questa continua cura ad “iniziare”, che non ha il fine di aumentare un numero, ma far emergere sul volto delle persone i tratti della fisionomia di Cristo, la somiglianza originale dei figli. È tempo, come ricorda il Documento di sintesi del Cammino sinodale, di allargare gli orizzonti dei percorsi iniziatici, perché «il modello catecumenale proprio dell’Iniziazione cristiana diventa il paradigma per la formazione in generale» [4].
L’importanza di favorire una crescita umana integrale
La dinamica iniziatica, in continuo movimento attraverso le dimensioni dell’esperienza di fede del discepolo-missionario, ha rappresentato negli anni il filo conduttore dei percorsi di iniziazione alla vita cristiana degli adulti, dei giovani e dei bambini e ragazzi. Si tratta di un percorso definito nel tempo, che ancora oggi richiama all’importanza di favorire una crescita umana integrale, che sia armonica e ponga al centro la vita, che apra alla relazione con un “Tu”, che dà significato alla fraternità degli uomini.
Eppure, in ogni età, ad ogni soglia esistenziale è necessario continuare ad approfondire il kerygma (l’annuncio primo del Vangelo) e interrogare la vita, anche di fede, alla luce dei cambiamenti. Occorre custodirsi “iniziati”, avendo attenzione, anche da giovani e adulti, a stare dentro il cammino mistagogico in seno alla comunità, il telaio che continua a tessere le esperienze di grazia e annuncio, ascolto della Parola e testimonianza.
Letta dentro questa dinamica formativa che è la vita della Chiesa, l’esperienza associativa di Azione cattolica è ancora traduzione attuale del fine apostolico: aver cura delle persone e dei processi mediante i quali formare coscienze laicali e manifestare «al mondo il messaggio di Cristo con la parola e i fatti e a comunicare la sua grazia» [5], perché ogni ambiente sia raggiunto dalla “notizia buona”, che è Parola viva ed efficace, e la comunità dei credenti sia lievito di pace e di speranza nella società.
Abitare la comunione attorno all’ascolto della Parola, alla grazia sacramentale e alla missione
I processi di cura costitutivi di una comunità iniziatica, infatti, sono ancora oggi una profezia per la società, quando camminano per le strade attraverso la vita di bambini e ragazzi, giovani e adulti e sono capaci di azioni trasformative che umanizzano le relazioni, i luoghi, le strutture. È necessario un annuncio incarnato, che sappia ascoltare le domande di senso che esprimono le persone e restare fedele alla vita. Tuttavia, esiste una tendenza a progettualizzare che, troppo spesso, si è proposta come soluzione all’attualizzazione della missione evangelizzatrice o al rinnovamento dei processi. Il cammino sinodale ha ricordato che il metodo stesso è espressione di contenuto e, nella sintesi che ci viene consegnata sull’essere Chiesa che ancora assume la cura ad iniziare alla vita cristiana, emerge l’invito alla comunità a “rientrare” in se stessa per abitare la comunione attorno all’ascolto della Parola, alla grazia sacramentale e alla missione.
Qualcuno potrebbe pensare che sia un movimento interiore, esclusivo, ma questo sarebbe riduttivo; definisce, invece, la postura con cui custodire una Chiesa aperta al rinnovamento. «Il “noi” ecclesiale è il soggetto che, mosso dalla grazia dello Spirito e fedele alla parola del Vangelo, opera il cammino dell’evangelizzazione» [6]. Il laicato associato, nella particolare forma dell’Azione cattolica, è animatore di questa responsabilità: nella relazione che salva e tutto rinnova, si inizia a partire da un “noi”.
Riferimenti
[1] Ufficio Catechistico Nazionale, Il catechismo per l’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi. Nota per l’accoglienza e l’utilizzazione del catechismo Cei, 15 giugno 1991, n. 7.
[2] Concilio Vaticano II, Lumen gentium, Costituzione dogmatica sulla Chiesa, n. 1.
[3] Conferenza Episcopale Italiana, Lievito di pace e di speranza. Documento di sintesi del Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia, n. 54.
[4] Ivi, n. 56.
[5] Concilio Vaticano II, Apostolicam actuositatem, Decreto sull’apostolato dei laici , nn. 6. 20.
[6] Conferenza Episcopale Italiana, Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia, n. 29.