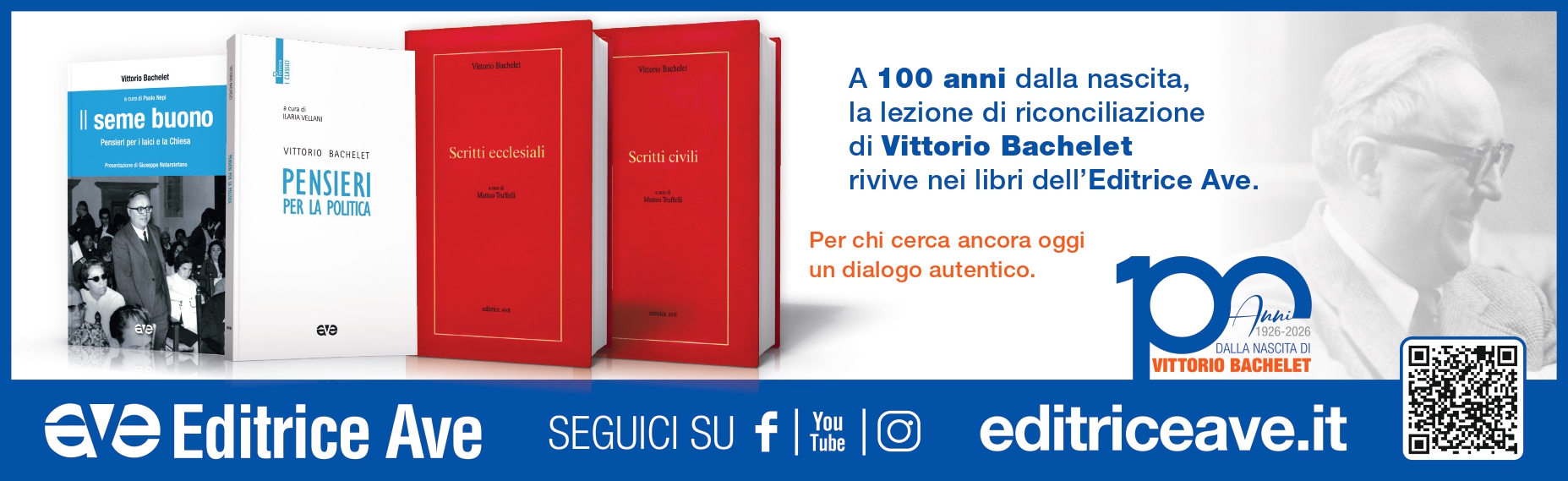Più di due milioni di bambini e ragazzi sotto i 16 anni in Italia vivono in famiglie a rischio di povertà o esclusione sociale. Un dato che, da solo, basterebbe a far suonare più di un campanello d’allarme. Ma non siamo di fronte a un’eccezione. È la conferma, amara e puntuale, di una frattura che continua ad allargarsi nel nostro Paese, colpendo in modo particolare chi ha meno voce: i bambini.
A dirlo è il nuovo approfondimento dell’Istat sulle condizioni di vita dei minori, su dati 2024. Un’indagine che non solo fotografa un presente difficile, ma delinea anche un futuro ipotecato per troppi. Il 26,7% dei minori italiani è esposto a condizioni economiche e sociali che compromettono la crescita, l’educazione, la salute. Percentuali che salgono vertiginosamente se si considerano i minori stranieri (43,6%) e quelli residenti nel Mezzogiorno, dove il rischio raggiunge a sua volta il 43,6%, con un picco drammatico del 78,2% tra i bambini stranieri nel Sud.
Quella che emerge è una diseguaglianza non solo marcata, ma strutturale e multidimensionale. Il rischio aumenta con il numero di figli, diventa critico nei nuclei monogenitoriali (oltre il 53% se ci sono due o più figli), e si trasforma in una quasi certezza quando i genitori hanno solo la licenza media inferiore (51,8%). Il contrasto è netto con i figli di laureati, tra i quali la percentuale scende drasticamente al 10,3%.
Dietro questi numeri si cela una povertà spesso invisibile, ma concreta. Legata a precarietà abitativa (più di un quarto delle famiglie con minori paga un mutuo o un affitto) e a quella che Istat chiama “deprivazione materiale e sociale”: una categoria che non riguarda solo la mancanza di risorse, ma descrive le rinunce quotidiane che tanti bambini sono costretti a subire.
Minori: deprivazione materiale e sociale
Secondo gli standard europei, un minore è in deprivazione materiale e sociale se sperimenta almeno tre delle diciassette condizioni considerate. Tra queste: non poter fare sport, non avere libri adeguati, giochi educativi, vestiti nuovi, un pasto proteico al giorno, un posto tranquillo dove studiare, cure mediche regolari. E ancora: niente gite scolastiche, niente vacanze, niente amici invitati a casa. Un elenco che disegna l’infanzia negata a tanti, troppi.
Nel 2024, l’11,7% dei bambini italiani vive in questa condizione, poco sotto la media europea (13,6%). Ma il dato più allarmante riguarda la gravità del fenomeno: oltre la metà di questi bambini soffre almeno sei segnali di disagio – erano il 36,2% solo tre anni fa. Non si tratta di qualche rinuncia occasionale, ma di un’infanzia interamente sacrificata, che rischia di diventare la norma in alcuni contesti.
Tra i segnali più gravi c’è l’insicurezza alimentare, che colpisce il 4,9% dei minori su scala nazionale, con punte dell’8,9% nel Mezzogiorno. Non stupisce, allora, che quasi un minore a rischio su due viva proprio nel Sud. Né sorprende che il rischio di povertà schizzi al 53,5% per chi cresce in famiglie monoreddito, contro il 18% nelle famiglie con più fonti di reddito. Il divario è netto, spietato.
La povertà è una trappola intergenerazionale
Ma l’indagine Istat è molto più di una radiografia dell’oggi: è una proiezione sul domani. In Italia, chi è cresciuto in povertà ha un rischio del 34% di restarci da adulto, quasi venti punti in più rispetto a chi proviene da famiglie agiate. È uno dei dati più alti d’Europa. A conferma che la povertà non è solo una condizione contingente: è una trappola intergenerazionale, che soffoca ogni prospettiva di mobilità sociale.
Ecco perché non possiamo più permetterci di archiviare questi numeri come l’ennesimo “rapporto allarmante”. L’indagine Istat è un appello alla responsabilità collettiva. Perché in un Paese dove nascere al Sud, da genitori stranieri o con bassa istruzione significa partire con uno svantaggio strutturale, ogni discorso sulla parità delle opportunità rischia di restare retorica vuota.
Se davvero vogliamo misurare la qualità di una società dal modo in cui tratta i suoi bambini, allora questi dati ci inchiodano. L’infanzia in Italia sta diventando il grande assente nei bilanci della ripresa economica. E invece dovrebbe essere la prima voce. Occorrono politiche strutturali, investimenti massicci in istruzione, sostegno alle famiglie, accesso equo ai servizi essenziali. Non si tratta solo di “aiutare i poveri”: si tratta di decidere se vogliamo essere un Paese capace di futuro. Perché ogni bambino escluso oggi è una ferita che il Paese porterà domani.