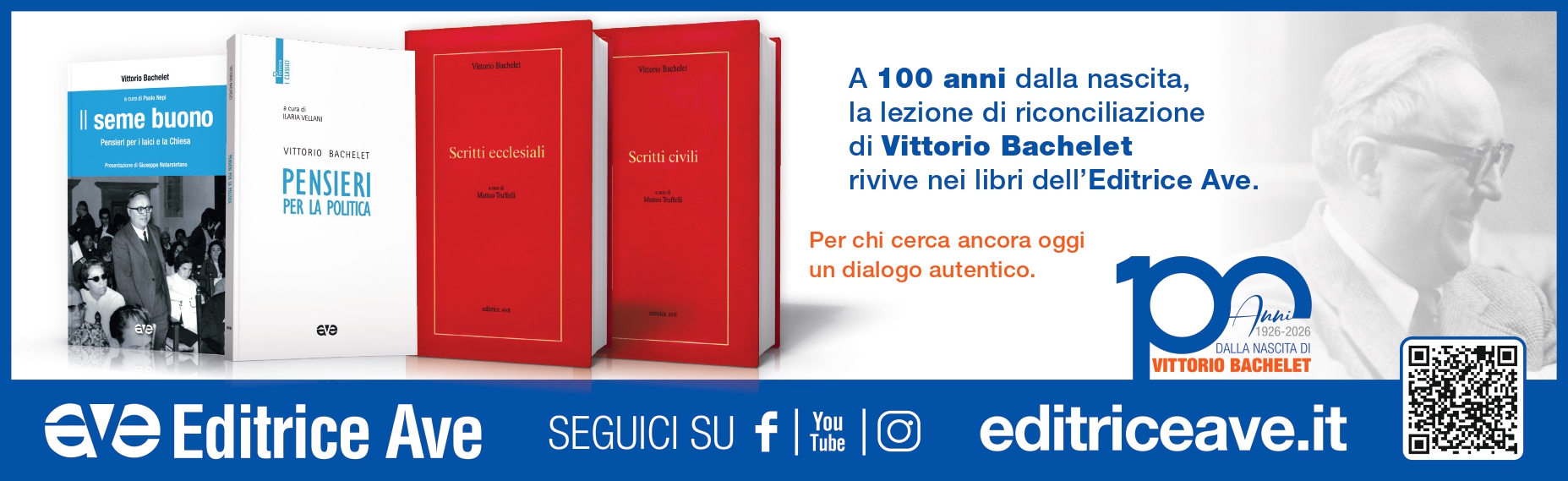Alle soglie del Duemila, per via del crescente fenomeno della secolarizzazione, in molti fra analisti e studiosi pensavano all’imminente scomparsa delle religioni. L’11 settembre del 2001 ha mostrato tragicamente che così non era. Infatti la strumentalizzazione del messaggio religioso ha condotto il mondo verso uno scontro nel quale, da un lato, i terroristi invocavano Dio prima della morte, dall’altro lato, il presidente degli Stati Uniti d’America chiedeva alla divinità di benedire i bombardieri pronti a fare strage di vite umane, anche innocenti.
Con la crisi del multilateralismo e di una certa globalizzazione, tanto in Occidente quanto nel resto del mondo, è tornato alla ribalta il costrutto cultural-politico dei nazionalismi che spesso, anche nella laicissima e modernissima Europa, si è saldato alla religione intesa come un elemento identitario da difendere dall’assalto dei “diversi”. Ciò è emerso in Francia con la proposta del Front National dei Le Pen, in Italia con il progetto nazionalista meloniano e salviniano, in Ungheria tramite la democrazia illiberale di Viktor Orbàn e negli Stati Uniti d’America prima con George W. Bush e adesso con Donald Trump.
Democrazie e religioni (e relativa strumentalizzazione)
In queste declinazioni politiche, come in molte altre sparse per il globo, la religione è concepita al pari di una porzione indispensabile della cultura del proprio popolo, la quale va difesa con le unghie e con i denti da chi appare come uno straniero per etnia e credo. Inoltre, le argomentazioni politiche e culturali di Charles Kirk – definito dal cardinale Timothy Dolan un «San Paolo moderno» – diffuse a livello planetario per via della sua tragica scomparsa, hanno rivelato quanto sia considerevole nelle nostre democrazie l’incidenza sociale, culturale e politica delle religioni e la relativa strumentalizzazione delle medesime. Oltre a ciò va ricordato il ragionamento teologico-politico che spinge la destra ultraortodossa israeliana ad un’azione politica e militare volta a conquistare una terra a parer loro destinatagli dal Signore della vita.
Da quanto emerge possiamo notare sia che le religioni non sono affatto scomparse sia che le stesse continuano ad esercitare in un modo o in un altro una considerevole incidenza all’interno delle comunità umane. Tuttavia, spesso, il dato religioso viene strumentalizzato per sostenere ora un progetto politico ora una corrente culturale o una determinata visione del mondo. Pertanto, urge rifarsi quanto più possibile allo spirito autentico che le religioni desiderano avanzare per gli uomini del XXI secolo e di ogni tempo. Per far ciò, forse risulta opportuno riprendere le riflessioni che papa Francesco ha scritto insieme al Grande Iman di Al-Azhar Ahmad Al Tayyeb nel Documento sulla fratellanza umana firmato a Abu Dhabi il 4 febbraio del 2019.
Religioni e cultura della tolleranza, della convivenza, della pace, della cura dell’ambiente
Per quel testo la fede assume una postura sociale quando porta il credente a «vedere nell’altro un fratello da sostenere e da amare» ciò perché, continua il documento, Dio ha creato «tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità, e li ha chiamati a convivere come fratelli fra loro». Ne deduciamo che in questa visione le religioni sono chiamate ad impegnarsi seriamente per diffondere una cultura della tolleranza, della convivenza, della pace, della cura dell’ambiente e dell’uomo nella sua integralità. Allora, scrivono papa Francesco e il Grande Iman Ahmad Al Tayyeb, le religioni non «incitano mai alla guerra e non sollecitano sentimenti di odio, ostilità, estremismo, né invitano alla violenza o allo spargimento di sangue».
Prima di prevedere la scomparsa di ogni forma di credenza e nel tentativo di non strumentalizzarle, in questo tempo di cambiamenti, conflitti e chiusure urge rifarsi al messaggio autentico delle religioni volto a sostenere una cultura della pace, del dialogo e della fraternità umana. Allora, come ha sostenuto Leone XIV lo scorso 30 settembre, le religioni in un mondo ferito da divisioni profonde non devono essere usate «come armi o muri ma vissute come ponti e profezia, per realizzare il sogno del bene comune e diventare lievito di unità in un mondo frammentato».