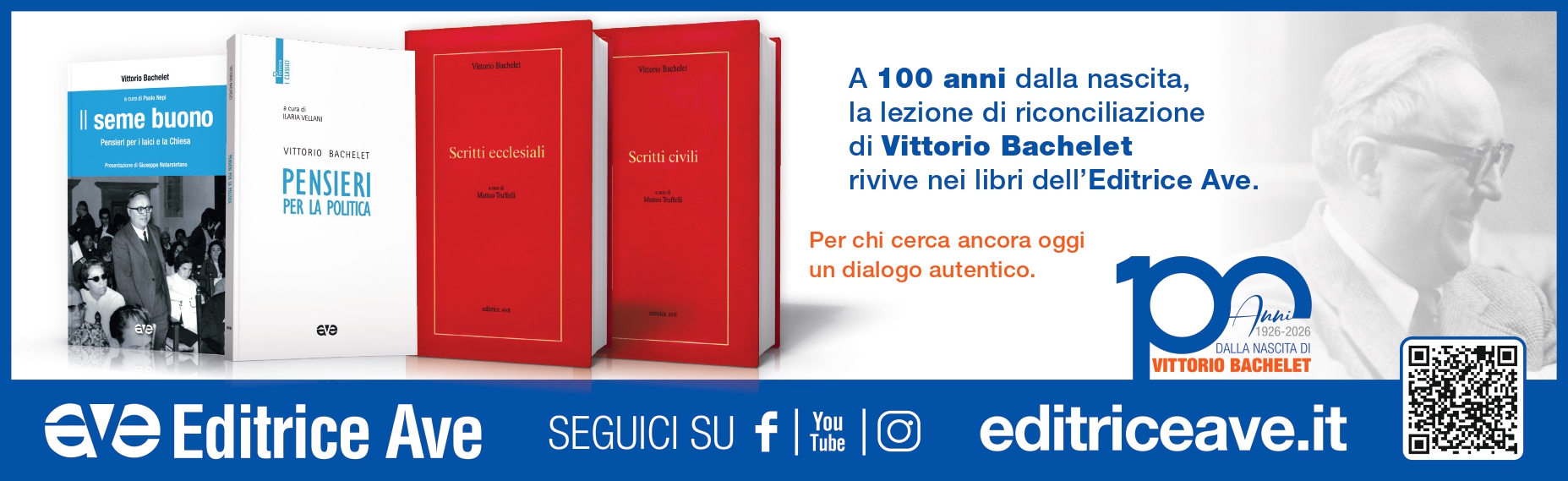Ci sentiamo impotenti. Forse arrabbiati, forse frustrati, a tratti disperati, ma certamente impotenti. Prima di scrivere ci siamo detti che volevamo essere onesti: scrivere come Emanuela e Lorenzo, due giovani che condividono la stessa fatica e la stessa disperazione davanti a questo senso di impotenza.
Allo stesso tempo andando oltre alle emozioni, razionalmente siamo consapevoli che nella storia di tutti, prima o poi, arriva il momento in cui si sperimenta l’impotenza. Per noi, oggi, quel tempo in modo particolare ha il volto delle persone che sono a Gaza e in Ucraina.
Questa mattina, confrontandoci come facciamo quasi tutti i giorni, ci ha assalito un vero e proprio disagio. Il disagio deriva da un silenzio che sta diventando faticoso e riguarda la capacità della nostra fede di interpellarci all’azione: contemplazione e azione possono andare di pari passo? Riusciamo a percepire contemporaneamente l’urgenza di abitare le piazze e di fermarci a pregare per la pace? Crediamo siano domande urgenti, da prendere sul serio. Ci chiedono se riusciamo a proporre l’abitare le piazze e il vivere la preghiera come “strumenti di cittadinanza”.
La nostra risposta è, innanzitutto, che non occorre scegliere. Entrambe le cose sono vere. Probabilmente, come generazione, abbiamo sviluppato una certa diffidenza verso la preghiera come azione politica. Ma è anche vero che percepiamo da giovani ancora troppo poco incisivo e troppo poco coraggioso il pensiero ecclesiale.
Ci sembra onesto dirlo, così come ci sembra altrettanto onesto dire che questa considerazione da giovani non è nuova: da sempre, in ogni generazione, l’animo giovanile non ama i compromessi annacquati. Parlando come Lorenzo ed Emanuela, possiamo dire che spesso le veglie per la pace rischiano di essere percepite da noi giovani come desideri di buon auspicio: sincere, ma poco provocatorie.
Va però detto che chi scende in piazza non lo fa soltanto per chiedere pace. Non vogliamo certo prestare il fianco a chi strumentalizza la violenza di pochi – che c’è stata e probabilmente ci sarà ancora – per screditare l’accorata partecipazione di tanti che chiedono più pace, più giustizia e meno tirannia. Ma è bene chiarire che, in piazza, non si invocherà solo la pace: si chiederà il riconoscimento della Palestina, che non si chiudano gli occhi davanti a un genocidio, che i governi fermino la pulizia etnica in corso; si invocherà la fine delle occupazioni illegali e la condanna dei responsabili, si chiederà che la gente torni a mangiare, i bambini a studiare, un popolo intero a vivere libero e ad autodeterminarsi. Si chiederà che su quella Terra Santa, che continuiamo a chiamare tale, cessino le maledizioni del sangue e abbondino finalmente benedizioni di pace.
La piazza, quindi, non chiede e chiederà semplicemente la fine della guerra. O meglio: non chiede pace a ogni costo, ma una pace giusta. Tante cose che, purtroppo, come Chiesa facciamo più fatica a dire ad alta voce. Per questo sentiamo di ringraziare l’attenzione che la Global Sumud Flotilla ha risvegliato: chi si è imbarcato, chi ha messo il proprio corpo per frapporsi all’ingiustizia, ci ha ricordato che nulla è ineluttabile. Scuotendoci dal nostro torpore, ci ha ricordato che partecipare è possibile, anche se è faticoso: richiede il mettersi in gioco, prendere posizione.
E tuttavia sappiamo qual è il peso della responsabilità che l’istituzione ecclesiale porta su di sé: è la croce di chi non può permettersi di essere neutrale, ma è chiamato a essere forza di mediazione. Da responsabili nazionali lo capiamo, eppure non possiamo nascondere che non per questo faccia meno male, che non per questo sia meno frustrante. Per questo comprendiamo perché oggi veglia di preghiera e piazza non abbiano lo stesso richiamo, soprattutto per i giovani: perché la responsabilità pesa, e fatica a coniugarsi con l’esigenza di radicalità che portiamo dentro.
Forse, allora, la strada possibile passa proprio da qui: benedire la voglia di scendere in piazza e, insieme, continuare a proporre esperienze significative di preghiera per la pace. Perché non si escludono a vicenda. Perché il silenzio della preghiera può commuovere, mentre il rumore della piazza può scuotere e, magari, il frutto della preghiera sarà una coscienza più viva.
Come laici, ci aspetta forse un compito difficile: essere presenti in piazza, lottare politicamente per le nostre idee, e nello stesso tempo radunarci in preghiera perché la pace e la giustizia che invochiamo siano piene, non contaminate dal rancore o dall’odio che la sete di vendetta rischia di generare.
Siamo chiamati ad assecondare la radicalità che spinge in piazza, ma anche a custodirla e filtrarla con la preghiera perché non degeneri in radicalismo. Non è forse questo il gesto più politico che possiamo immaginare? La preghiera può diventare il luogo in cui rimanere radicali nelle richieste e nelle azioni politiche senza trasformarsi in uomini e donne radicalizzati. Forse così diventiamo più credibili, forse così diventiamo attraenti. Perché piazza e Chiesa, per una cittadinanza credente, devono essere considerate entrambe indispensabili.
È tempo di essere presenti in piazza – ognuno nella piazza che ritiene più efficace – e di pregare perché la pace e la giustizia che invochiamo siano piene.