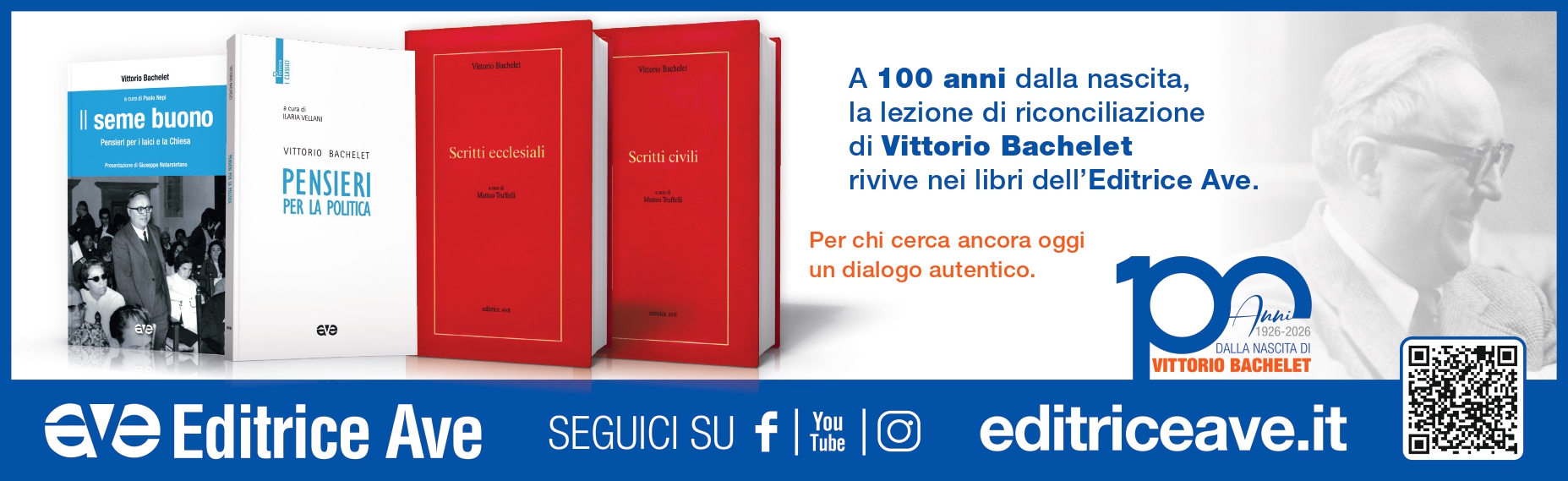Il dibattito politico in queste settimane appare ancora di più polarizzato e condotto con un linguaggio sempre più pervaso da risentimento e animosità. Molti osservatori hanno parlato di un crescente odio sociale che acceca i protagonisti della politica, annebbia le ragioni e le motivazioni del conflitto, aizza allo scontro e alla violenza ad ogni livello della vita sociale. Anche la vita sociale come l’economia produttiva e finanziaria sembrano cercare nuovamente l’assetto della guerra, antico e banale sin dagli albori della storia umana.
Ma i cittadini come si pongono rispetto a questo avvitamento della discussione pubblica? Partecipano sempre meno come spettatori e più come “gladiatori” per utilizzare la celebre scala di Milbrath?
L’approssimarsi di un appuntamento elettorale come quello delle elezioni regionali riaccende il dibattito sull’effettivo coinvolgimento dei cittadini italiani alla vita politica del nostro Paese.
La crescente astensione elettorale e la forte volatilità dei sondaggi elettorali rende il lavoro delle società specializzate nel formulare previsioni diventa più arduo e complesso. D’altro canto, il paradosso della società dell’informazione appare sempre più evidente: l’eccesso di informazione disponibile offerto dai nuovi strumenti tecnologici non necessariamente si traduce in conoscenza e capacità di valutare oggettivamente ed autonomamente le proprie scelte in campo economico, sociale e politico.
I dati diffusi questa settimana dall’Istat misurano in modo rigoroso un aspetto specifico ma rilevante della partecipazione alla vita politica dei cittadini italiani che si concretizza nella capacità e volontà di informarsi sulla vita politica del Paese, esercitando così in modo attivo un pezzo importante del proprio diritto di cittadinanza. L’interessante report dell’Istat va oltre la superficie di questo fenomeno, misurando non solo aspetti individuali ma anche relazionali. I numeri parlano chiaro.
È come se la politica fosse diventata un linguaggio straniero
Nel 2024 oltre 15 milioni di persone hanno dichiarato di non informarsi mai di politica. Quasi due terzi lo fanno per semplice disinteresse, mentre più di un quinto (22,8%) indica la sfiducia come ragione di fondo.
È come se la politica fosse diventata un linguaggio straniero: distante, complicato, non necessario. Un’Italia in cui i giovanissimi (14-17 anni) si informano settimanalmente solo nel 16% dei casi, mentre il 60% confessa di non interessarsi mai all’attualità politica. Anche tra i giovani adulti, la metà si tiene alla larga dal dibattito pubblico. Il già rilevante declino demografico che caratterizza il nostro Paese sembra quindi accompagnarsi ad una più intensa flessione nella partecipazione politica visto che le generazioni più giovani si allontanano ancora più rapidamente di quelle anziane dalla partecipazione attiva nel Paese, rendendo il primo ancora più drammatico ed irreversibile.
La fotografia scatta anche altre differenze: territoriali e nei livelli di educazione. Il Mezzogiorno continua a mostrare livelli di partecipazione più bassi rispetto al Centro-Nord.
In Calabria, Sicilia e Campania quasi un terzo delle famiglie non si informa mai di politica: un dato che diventa drammatico se si pensa che proprio in quelle regioni si avverte con più forza il bisogno di politiche pubbliche capaci di affrontare disoccupazione, povertà e infrastrutture carenti. E ancora: chi ha un titolo di studio più basso partecipa molto meno, a conferma che educazione e informazione restano i veri anticorpi contro l’indifferenza.
Ma c’è di più nel report dell’Istat. Non è solo la partecipazione visibile – andare a un comizio, a un corteo, firmare una petizione – a ridursi drasticamente. È soprattutto la partecipazione invisibile, quella che si consuma nelle case e nelle relazioni, a mostrare i segni di un logoramento più profondo. Oggi quasi cinque milioni di famiglie italiane non parlano mai di politica. In sette milioni e mezzo di nuclei, almeno uno degli aspetti fondamentali della democrazia – informarsi, discutere, confrontarsi – è completamente assente. Non è un dettaglio: una democrazia senza conversazione quotidiana si riduce a rito svuotato, a delega cieca, a spettacolino da consumare passivamente. Il rischio, allora, non è tanto l’autoritarismo che bussa alle porte – pure sempre possibile – quanto l’assuefazione al silenzio e l’apatia, per citare sempre Milbrath.
La democrazia muore anche quando i cittadini smettono di esserci
La democrazia non muore soltanto sotto i colpi di mano, ma anche quando i cittadini smettono di esserci, quando rinunciano alla fatica di informarsi e di discutere, quando scelgono la comodità del disimpegno.
È il silenzio, forse più del rumore, a svuotare le istituzioni. Un silenzio che diventa incubatore di rabbia e violenza e che rischia di partorire gesti estremi e disumani.
Questo processo ha delle cause che non possiamo continuare ad ignorare. La prima è la sfiducia, radicata in decenni di promesse mancate e scandali che hanno logorato la credibilità della politica nel suo complesso. La seconda è la sensazione che i processi democratici siano troppo lenti, incapaci di rispondere ai bisogni concreti delle persone. La terza è la crisi dei luoghi di mediazione: partiti, associazioni, sindacati, comunità territoriali che un tempo erano palestra di cittadinanza oggi non riescono più a esercitare attrazione, soprattutto tra i più giovani.
Non possiamo fermarci alla diagnosi. Come è emerso anche durante la Settimana Sociale di Trieste, la politica deve certamente fare la sua parte, recuperando credibilità, trasparenza, concretezza, ma resta decisivo il ruolo di ciascun cittadino. Non basta denunciare la distanza: occorre ridurre lo scarto tra lamentele e partecipazione, tra la protesta delegata ad un post sui social e il confronto vero, quotidiano, con chi ci sta accanto. La politica non è solo “quella dei palazzi”: è anche quella che prende forma nelle scuole, nei condomini, nelle parrocchie, nei luoghi di lavoro.
Il ruolo delle comunità – civili, sociali, religiose – diventa decisivo
È il contrario di una vita avara ed egoista, per citare don Milani. D’altro canto, la tecnologia sta cambiando profondamente il modo con cui i cittadini si rapportano alla politica. L’aumento delle opinioni espresse online – oltre dieci milioni e mezzo di cittadini hanno usato nel 2024 i social per intervenire su questioni politiche – indica che la voglia di dire la propria non è scomparsa. Ma occorre che quella voce non resti confinata al flusso di un algoritmo, dispersa in un mare di like e commenti, incapace di trasformarsi in azione collettiva. Il ruolo delle comunità – civili, sociali, religiose – diventa decisivo. Serve un’educazione alla cittadinanza che non si contenti di una pur necessaria alfabetizzazione scolastica, ma che diventi esperienza viva di partecipazione.
Servono sia luoghi reali che virtuali in cui le persone possano riappropriarsi del senso di prendersi carico di sfide che sempre sono più complesse e che accomunano anche quando di fronte ad essa ci sono idee e vie di diverse di soluzione. La comunità si rigenera, ce lo ha mostrato l’esperienza sinodale, se è pratica di ascolto reciproco, di discussione franca e di confronto argomentato e competente. Così si anima un protagonismo che aiuta le persone a sentirsi tali e non nodi di una rete anonima. Serve, in altre parole, una cultura politica intesa non come potere di critica a distanza, ma come riconoscimento della complessità e, quindi coinvolgimento e assunzione di responsabilità.
La politica riguadagni la fiducia delle persone
Non possiamo permetterci che il futuro della democrazia – italiana ma non solo! – sia quello di una “democrazia muta”, dove pochi parlano e decidono, mentre la maggioranza resta spettatrice passiva. Perché una democrazia senza voce diventa presto terreno fertile per chi vuole manipolare, lo stiamo vedendo in diverse situazioni non lontane da noi, per chi preferisce cittadini consumatori piuttosto che cittadini pensanti.
I dati Istat ci mostrano una cosa tanto semplice quanto drammatica: la partecipazione dei cittadini alla vita politica del nostro Paese tende ad incrociarsi con altre povertà e distanze e rischia di essere fonte di ulteriori problemi piuttosto che il punto di partenza per la loro soluzione. È necessario ridurre queste distanze costruendo ponti e non scavando ulteriori solchi tra politici e società civile basati sulla paura e sulla diffidenza reciproca.
Tocca alla politica riguadagnare la fiducia delle persone. Ma tocca anche ai cittadini riapprendere la fatica e la bellezza del confronto. Tocca alle famiglie, alle scuole, alle associazioni, alle comunità cristiane – che hanno sempre avuto una tradizione viva di educazione sociale – arricchire il vocabolario delle persone educandole a prendere parola nello spazio pubblico, ma in modo argomentato e soprattutto dialogante. In questa prospettiva si riapre uno spazio di iniziativa e di azione per i credenti che vogliono impegnarsi secondo i criteri che offre la Dottrina Sociale della Chiesa.
Perché, alla fine, la democrazia vive o muore non nei palazzi, ma nelle case e nelle piazze, nelle relazioni e nelle scelte quotidiane. E se oggi prevale il silenzio, domani altri riempiranno quel vuoto.
È nostra responsabilità oggi decidere se lasciare che accada, o se ricominciare a prenderci cura insieme di quello spazio libero di espressione e di confronto necessario per trovare insieme la via del Bene di tutti.