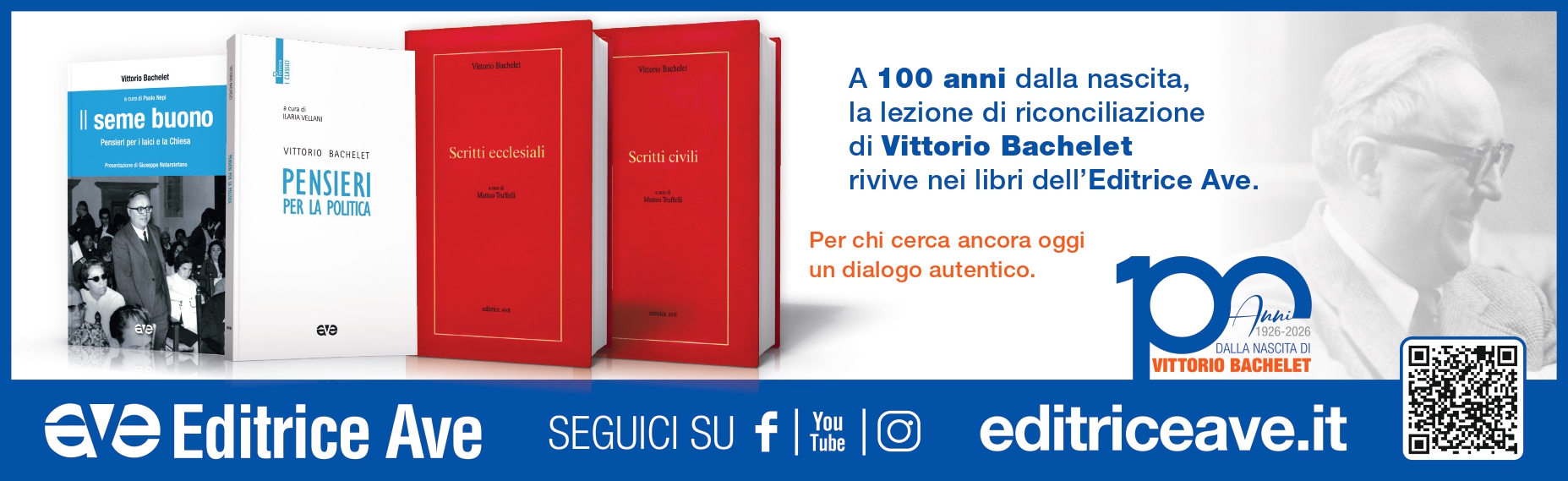Come siamo arrivati alle policrisi globali di oggi? La Prima Guerra Mondiale introdusse nuove e devastanti tecnologie belliche, portando una distruzione senza precedenti: venti milioni di morti, metà dei quali civili, e coinvolgendo oltre venti nazioni. La tragedia spinse gli Stati a ricercare strumenti per impedire il ripetersi di simili disastri. La Società delle Nazioni, fondata nel 1920, fu un primo tentativo di preservare la pace attraverso la sicurezza collettiva, ma la mancata adesione degli Stati Uniti ne indebolì l’efficacia.
La Carta delle Nazioni Unite nel 1945 riaffermò e ampliò tale impegno, vietando minaccia e uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di altri Stati. Gli Stati si adoperarono per creare istituzioni che consolidassero questa regola, privilegiando strumenti economici piuttosto che militari per la tutela della pace. L’espansione degli scambi e la proibizione della guerra divennero complementari: gli Stati, non potendo più arricchirsi con le conquiste, dovettero puntare su cooperazione, concorrenza e libero flusso di beni e capitali.
Nel 2025, mente si celebra l’ottantesimo compleanno della Carta, la volontà di meno di una decina di governi (su 193 paesi membri dell’ONU) di rinunciare al divieto di guerra rappresenta una minaccia pericolosa e riporta il mondo indietro di un secolo e più, a tempi in cui la forza era il parametro della giustizia. Riesumando l’idea che la guerra e la conquista siano strumenti legittimi per risolvere dispute e ottenere concessioni.
I recenti conflitti (Ucraina, Palestina, Myanmar, etc.) hanno ottenuto nell’Assemblea delle Nazioni Unite una risposta quasi unanime con il consenso di oltre 150 paesi, contro meno di dieci paesi dissenzienti, ma il diritto di veto nel Consiglio di Sicurezza ha reso inefficaci quelle decisioni. Per questo, dopo l’invasione russa dell’Ucraina, è stata introdotta la “iniziativa di veto”, che trasferisce all’Assemblea Generale il dibattito su risoluzioni bloccate dal veto in Consiglio di Sicurezza. Ciò ha permesso agli Stati di coordinare sanzioni, fornire sostegno all’Ucraina e avviare percorsi di riparazione post-bellica.
Le coalizioni regionali e tematiche stanno inoltre rafforzando il rispetto delle decisioni delle corti internazionali e promuovendo partnership per la pace, indipendentemente dagli Stati Uniti. Anche in quest’area del diritto internazionale due più due fa quattro: silenziare i rapporti ONU sul genocidio in Palestina non può cambiare la realtà dei fatti.
Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU rimane formalmente l’unico organo autorizzato ad approvare l’uso della forza per far rispettare la legge, ma nulla vieta la creazione di organismi alternativi per sanzionare congiuntamente le violazioni. Un coordinamento più rapido e coerente delle sanzioni potrebbe aumentarne l’efficacia.
Come negli anni ’40 si cercò di costruire la pace dal caos della guerra, oggi i leader devono progettare istituzioni e strategie per garantire la pace, senza restare spettatori di un ritorno alla politica della forza dei prepotenti.
Il Segretario generale dell’ONU più di una volta ha ribadito che la cooperazione internazionale non è un’utopia, ma una necessità. Nessun Paese può fermare da solo una pandemia, nessun esercito può arrestare l’aumento delle temperature, nessun algoritmo può ricostruire la fiducia una volta persa: serve pragmatismo di fronte alle minacce globali condivise. In questo momento di crisi, le Nazioni Unite sono più essenziali che mai, grazie alla loro legittimità, capacità di aggregazione e visione di unire le nazioni per superare le sfide future. Nessuno finora ha proposto un’alternativa più giusta o più efficace.
Cinque sono le scelte cruciali per i governi.
Pace anziché guerra: I conflitti dal Sudan all’Ucraina, a Gaza dimostrano il costo dell’inosservanza del diritto internazionale. La Carta dell’ONU è il fondamento, non un’opzione. Servono cessate il fuoco, responsabilità e diplomazia.
Dignità e diritti: I diritti umani sono la base della pace. La tutela delle libertà civili deve essere accompagnata da finanziamenti per lo sviluppo, favorendo investimenti in salute, istruzione e pari opportunità. Il bilancio globale dell’ONU con questi obiettivi costa meno di un decimo del bilancio dell’istruzione nella sola città di New York.
Giustizia climatica: I combustibili fossili rappresentano una scommessa persa. Occorre accelerare la transizione verso le energie rinnovabili, rafforzare gli impegni nazionali sul clima e aumentare i fondi per i paesi vulnerabili. La scienza indica che limitare l’aumento della temperatura a 1,5 gradi è ancora possibile, ma il tempo stringe.
Tecnologia al servizio dell’umanità: L’intelligenza artificiale e gli altri strumenti devono essere gestiti con responsabilità. Nessuna macchina dovrebbe decidere chi vive o muore: sono necessari standard globali decisi insieme per mantenere la tecnologia al servizio delle persone.
Un’ ONU più forte: Con la crescita delle crisi, l’Onu deve adattarsi e ricevere finanziamenti adeguati. Persiste uno squilibrio: per ogni dollaro investito nella costruzione della pace, se ne spendono 750 in armi da guerra.
Rimettere l’orologio indietro di cento anni per tornare al caos della prepotenza dei più forti, in un mondo governato da 193 nazioni, sarebbe una disfatta irreparabile dell’umanesimo. I discorsi fatti all’assemblea degli 80 anni ONU passeranno alla Storia come testimonianze sui responsabili. Ma il diritto internazionale non è un castello di carte che cade se una o due si ritirano. Per far fallire il diritto internazionale servono anche l’indifferenza, l’accidia e l’egoismo di molte altre nazioni e soprattutto il silenzio dei loro popoli.