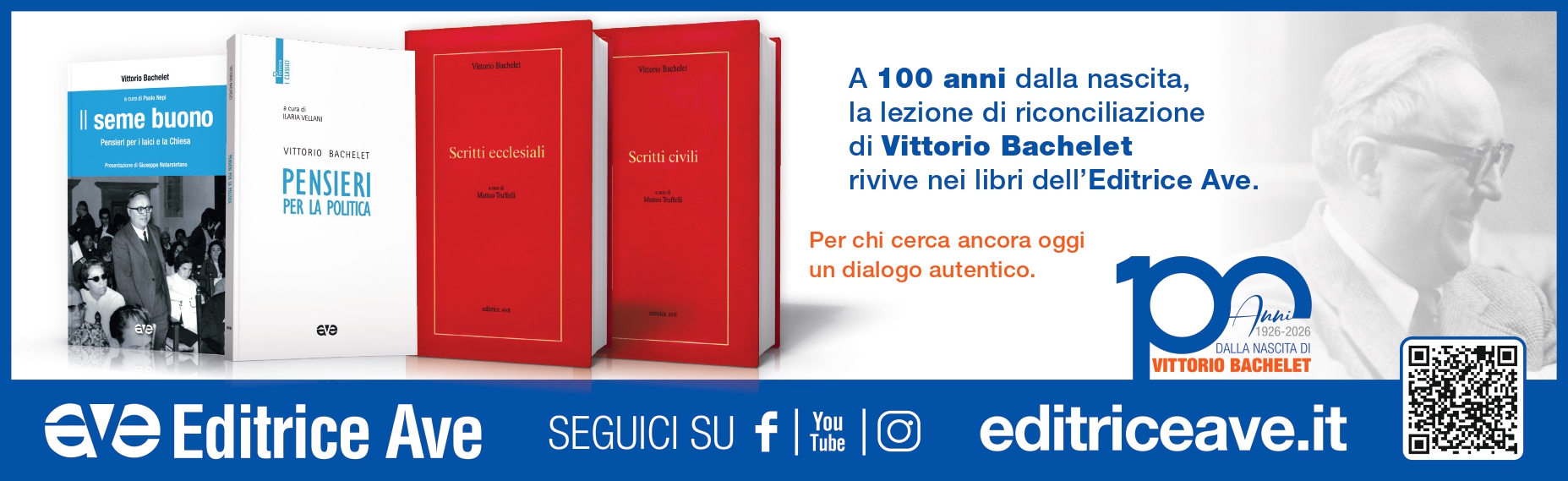La sera del 24 dicembre 1299 una folla imponente si ritrovò dentro e fuori l’antica Basilica di San Pietro con la convinzione che si stesse concedendo una “perdonanza” straordinaria per l’inizio del nuovo secolo. Il fenomeno di devozione popolare si ripeté anche nei giorni successivi. Si fece appello a una tradizione immemorabile, secondo la quale l’anno centenario doveva essere considerato tempo di perdono e riconciliazione universale.
La questione dell’anno centesimo
Le parole del cardinale Jacopo Stefaneschi permettono di conoscere gli eventi: «Il romano pontefice Bonifacio VIII era stato messo al corrente dell’opinione dubbia e quasi priva di attendibilità (…). Per questo motivo ordinò di ricercare prove dell’opinione corrente nei documenti posseduti dalla Cancelleria apostolica ma le indagini non vennero a capo di nulla. (…) Bonifacio VIII non volendo contrastare la religiosità popolare, consultò il collegio dei cardinali sulla questione dell’anno centesimo, non ancora risolta e, ottenuto parere favorevole in funzione dei meriti degli apostoli, ordinò di preparare una minuta allo scopo di raggiungere la verità con maggiore chiarezza, per meglio discutere sulla questione del privilegio».
Nella Bolla Antiquorum habet, Bonifacio VIII affermava: «Concediamo a tutti che nel presente anno 1300 iniziato dalla vicina passata festa della Natività del Signore Nostro Gesù Cristo, e in ogni anno centesimo che seguirà, (…) una pienissima perdonanza di tutti i loro peccati». Si dava inizio al primo Anno Santo, tempo di grazia e di rinnovamento della fede attraverso il pellegrinaggio e l’indulgenza.
Il pellegrinaggio
Il pellegrinaggio era un cammino esistenziale: si partiva per cercare in Dio il senso della propria vita e molti erano i penitenti che desideravano ritrovare la pace interiore grazie alla misericordia ricevuta. Il pellegrino era considerato un alter Christus perché imitava il Figlio di Dio e per suo amore si privava di ogni umana sicurezza, conforto e affetto umano, mettendo a repentaglio la propria sopravvivenza. Tutto questo era considerato un’autentica testimonianza di fede. A spingere tantissimi fedeli a compiere il pellegrinaggio alle tombe dei santi Pietro e Paolo era la possibilità di ricevere l’indulgenza, esperienza di misericordia e conversione, occasione per riflettere sulla propria vita e ravvivare la speranza nella salvezza offerta da Dio come dono gratuito e immeritato.
Tra misericordia e carità: Giubilei, la via della rinascita
Dopo lo scisma luterano e con l’affermarsi delle idee del Concilio di Trento si volle dare una veste nuova al Giubileo con un’attenzione particolare alla cura delle condizioni materiali e spirituali di poveri, pellegrini e carcerati: la misericordia divi- na fu coniugata con la carità cristiana.
Pochi anni dopo il Concilio Vaticano II, Paolo VI spiegava – nell’udienza del 9 maggio 1973 – l’attualità del Giubileo: «Ci siamo domandati se una simile tradizione meriti d’essere mantenuta nel tempo nostro, tanto diverso dai tempi passati, e tanto condizionato, da un lato, dallo stile religioso impresso dal recente Concilio alla vita ecclesiale, e, dall’altro, dal disinteresse pratico di tanta parte del mondo moderno verso espressioni rituali d’altri secoli; e ci siamo subito convinti che la celebrazione dell’Anno Santo, non solo può innestarsi nella coerente linea spirituale del Concilio stesso, alla quale preme a noi di dare fedele svolgimento, ma può benissimo corrispondere e contribuire altresì allo sforzo indefesso e amoroso che la Chiesa rivolge ai bisogni morali della nostra età, all’interpretazione delle sue profonde aspirazioni, ed anche alla onesta condiscendenza verso certe forme delle sue espressioni esteriori preferite. È necessario a questo molteplice scopo mettere in evidenza la concezione essenziale dell’Anno Santo, ch’è il rinnovamento interiore dell’uomo», affermò papa Montini, annunciando il Giubileo del 1975.
Il Giubileo del 1300 è nato sotto la spinta di un movimento spontaneo del popolo di Dio e ha portato nel corso dei secoli a un rinnovamento per la Chiesa e il mondo intero.