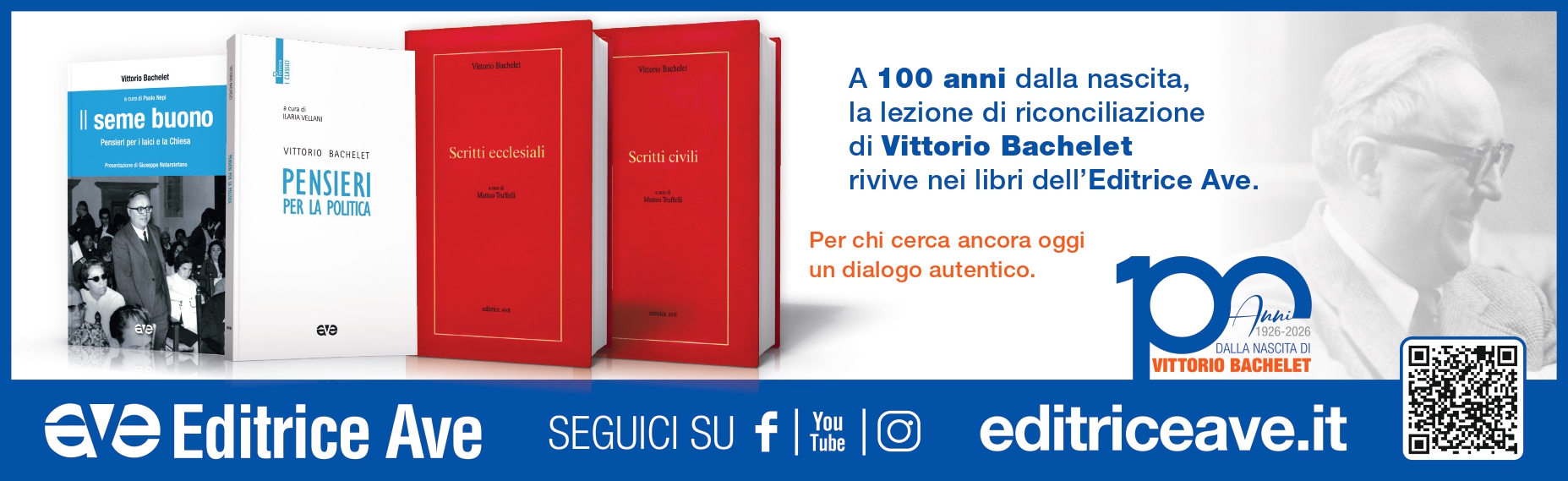In una città che i dati macroeconomici danno in evidente crescita, crescono pure le disuguaglianze, cioè le distanze in termini di condizioni economiche, di opportunità di crescita sociale e di accesso a fondamentali diritti, creando differenze a seconda dell’età, del genere, della cittadinanza di nascita, della composizione dei nuclei familiari. Il Rapporto 2024 della Caritas di Roma, La povertà a Roma: un punto di vista. Tra indifferenze e speranze, conferma come la Capitale sia la cartina di tornasole del Paese e rifletta i molteplici paradossi di un modello economico che tende ad aumentare ovunque l’area della marginalità, senza offrire grandi chance di ripresa.
Le povertà sono molteplici e spesso tra loro interdipendenti: abitativa, educativa, lavorativa, relazionalee e sanitaria. Per uscirne occorrono politiche pubbliche e forme di solidarietà convergenti per restituire dignità e fiducia alle troppe persone che ne sono vittime. Il “problema”, però, sono le notevoli difficoltà che abbiamo per fare il primo passo, per aprire il cuore e la mente, per riconoscere nei poveri i fratelli e le sorelle da accogliere e accompagnare. Cresce anche l’incapacità di sapere cogliere i volti meno scontati della povertà. Le solitudini, la disperazione delle vite di tanti ragazzi e giovani, facili prede delle numerose forme di dipendenza da consumismo, da sostanze, da scommesse, da sesso, da alcolici e violenza. Il Giubileo della Speranza ci sollecita a una nuova conversione e a gesti concreti di solidarietà verso coloro che sono afflitti da legami e da vincoli di schiavitù insostenibili.
Tra indifferenze e speranze
In questo inizio del terzo millennio ci troviamo in un tempo che oscilla continuamente tra indifferenze e speranze. Le indifferenze sono quelle che sembrano avvolgere un’area piuttosto ampia di persone che guardano a questi problemi e a questi limiti come se fossero del tutto estranei alle proprie responsabilità, al proprio vissuto fatto di scelte e di decisioni. Qui come Chiesa dobbiamo riscoprire la dimensione della carità politica, il vero antidoto all’assistenzialismo, per intervenire sulle cause di troppe forme di povertà e rilanciare una stagione di partecipazione alla vita pubblica, attingendo al patrimonio della Dottrina Sociale della Chiesa.
Il cambiamento nelle nostre città passa pure per un forte investimento sulla formazione e sull’educazione culturale. «Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli opeai!» (Mt 9,37). Certo servono modalità e una creatività adatte ai nostri tempi, ma occorrono “operai” e credo che qui ci sia una vocazione, una chiamata e una responsabilità che anzitutto gli amici dell’Azione cattolica possono assolvere con grande spirito di servizio nei confronti della Chiesa di Roma. Le speranze per noi sono certamente fondate sull’amore misericordioso illimitato di Dio Padre verso tutti e sulla nostra testimonianza della carità, personale e comunitaria, attraverso i segni di bene e di generosità. Per passare dalle indifferenze alle speranze, possono aiutarci cinque verbi.
È tempo di una carità politica. Ricucire
In occasione dell’Assemblea diocesana dello scorso 25 ottobre e alla presenza del nostro vescovo papa Francesco, dopo un percorso di confronto e di riflessione durato un anno e svolto nelle periferie romane, su alcune gravi (dis)uguaglianze relative all’abitare, alla scuola, al lavoro e alla sanità, il vicario generale del Santo Padre per la diocesi di Roma, il cardinale Baldassare Reina, nel suo intervento introduttivo, ha usato parole inequivocabili: «Attorno a queste problematiche vorremmo chiamare a raccolta tutti e ciascuno con la propria responsabilità. Ci piacerebbe creare delle occasioni stabili di confronto e di collaborazione con le istituzioni, con il vasto mondo delle associazioni, con gli uomini e le donne di buona volontà a cui sta a cuore il bene della persona umana e insieme lavorare per seminare speranza».
Riconoscere
Il buono, l’impegno, il costruire, il fare bene, la generosità e la gratuità del dare e del donare, le realizzazioni che già ci sono a Roma. I molteplici germogli di speranza, gli esempi di impegno e di dedizione, i progetti e le innovazioni nei servizi di pubblica utilità, nei quartieri, nelle pubbliche amministrazioni, nel volontariato, nella scuola, nell’università, nella ricerca, nelle comunità religiose, nel mondo dell’arte, della cultura, dell’informazione e dello spettacolo di Roma.
Riorganizzare
Appare ormai evidente come l’assetto normativo, regolamentare e amministrativo della nostra città sia del tutto inadeguato. Si parla da decenni, con diverse proposte legislative, per Roma Capitale, della necessità di dotarla di maggiori poteri e risorse, come avvenuto per le altre grandi capitali in Europa. È un’esigenza vitale per Roma e per tutto il Paese. È uno stallo che a fronte delle legittime aspettative di chi vive la città, rischia di accentuare quel distacco tra istituzioni e cittadini.
Rieducare
Si tratta di avviare un impegno complessivo per prevenire e almeno ridurre quella indifferenza diffusa e consentire a tutti di acquisire o recuperare dei contenuti educativi fondamentali che cambino la prospettiva.
Rischiare (È tempo di una carità politica)
È il tempo di osare, come il nostro Vescovo sollecita spesso. I problemi della Capitale sono seri, complessi e certo non recenti. Per affrontarli occorre un terreno comune di impegno tra i diversi attori: scelte, misure, investimenti, programmi d’intervento a breve, medio e lungo termine in grado di incidere sulle cause dei problemi.
*L’autore dell’articolo, È tempo di una carità politica, è il direttore della Caritas diocesana di Roma. La riflessione è stata ospitata da Segno nel mondo nel primo numero di quest’anno pubblicato il 24 di gennaio con il quotidiano Avvenire