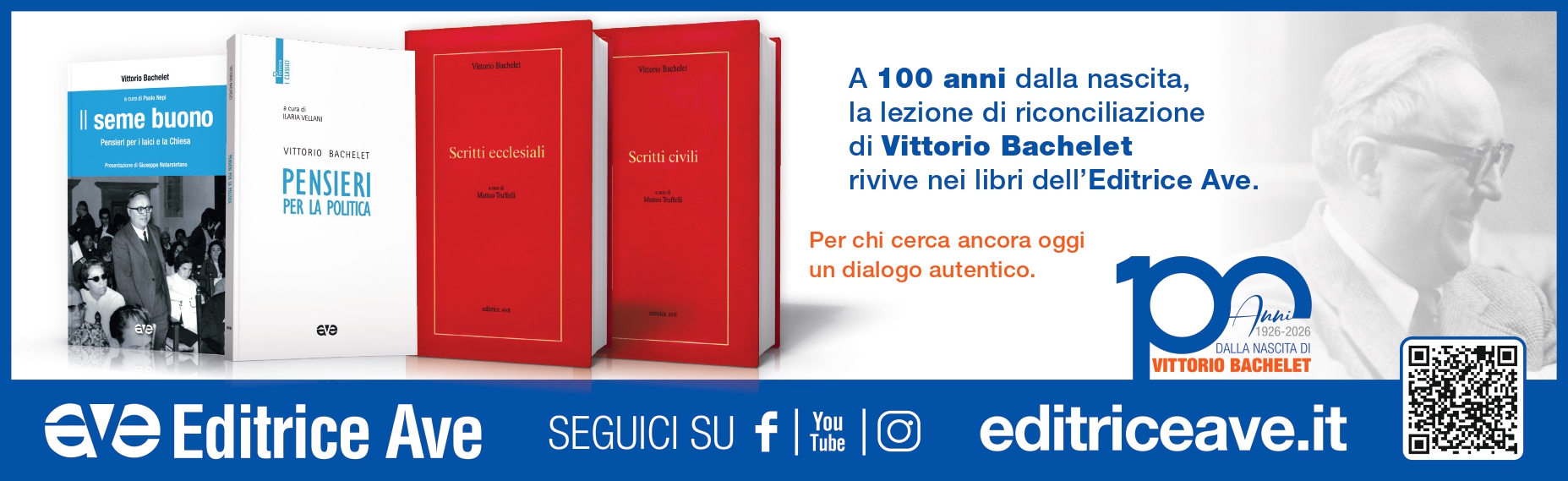In psicologia esiste una teoria per descrivere un particolare fenomeno legato al modo che le persone utilizzano per elaborare le informazioni con cui quotidianamente si interfacciano. Si tratta della Teoria del Livello di Concretizzazione, secondo cui gli individui tendono a percepire lontani, nel tempo, nello spazio o socialmente, gli eventi che non riguardano direttamente la loro esperienza personale.
Un’applicazione piuttosto concreta di questa teoria si riscontra in riferimento a tutte le questioni che ruotano attorno al mondo del Carcere. Nonostante gli appelli di Papa Francesco, si pensi alla scelta di aprire la Porta Santa nel Carcere di Rebibbia o alle celebrazioni del Giovedì Santo svolte con i detenuti, e del Presidente Mattarella, che da ultimo in occasione del 50° anniversario dell’Ordinamento Penitenziario ha rimarcato la necessità di uno sforzo congiunto volto ad assicurare il pieno rispetto dei diritti dei detenuti, il tema delle condizioni carcerarie fatica a entrare stabilmente nel dibattito pubblico e a suscitare riflessioni politiche più ampie e slegate da logiche emergenziali.
Il Rapporto Antigone: un report sullo stato delle Carceri
Un importante tentativo di compensazione della scarsità di attenzioni su ciò che riguarda il Carcere è rappresentato dal Rapporto di Antigone[1], un report annuale, curato dall’omonima associazione, volto a sensibilizzare e informare su quanto avviene ogni anno all’interno delle strutture detentive.
Il Rapporto fornisce dati e numeri sullo stato delle Carceri, provando a raccontare le questioni più spinose che questa realtà ci consegna: l’emergenza dei suicidi, le disastrose condizioni degli istituti, le spesso disumane condizioni detentive, il rispetto dei diritti dei detenuti e molto altro.
I numeri che ci racconta la gravità della situazione nelle Carceri:
- Al 30 aprile 2025 erano 62.445 le persone detenute nelle carceri italiane. A fronte di queste presenze la capienza regolamentare è di 51.280 posti, un dato addirittura in lieve calo rispetto alla fine del 2024, e dunque il tasso di affollamento ufficiale sarebbe del 121,8%. Però, i posti non disponibili per inagibilità o ristrutturazioni sono almeno 4.500, e dunque il tasso medio effettivo di affollamento è almeno del 133%. In due anni la capienza effettiva è calata di 900 posti, mentre le presenze sono aumentate di oltre 5.000 unità.
- Il sistema minorile, che fino a poco tempo fa era considerato da esempio per gli altri Stati, sta sperimentando il fenomeno del sovraffollamento, anche in conseguenza degli ultimi provvedimenti legislativi di stampo fortemente punitivo. Alla fine del 2022 le presenze erano 381 e alla fine del 2024 raggiungevano le 587 unità, con una crescita del 54% in due anni (A questi numeri bisogna aggiungere i detenuti nelle comunità per minori, che al 31 marzo erano 1146). La metà dei minori detenuti è composta da stranieri non accompagnati.
- Sono presenti solo 963 educatori, una media di un educatore ogni 65 detenuti, a testimonianza di quanto sia difficile strutturare percorsi rieducativi efficaci per ciascun detenuto.
- Il 44% delle persone detenute fa uso di sedativi o ipnotici, il 20% usa stabilizzanti dell’umore, antipsicotici e antidepressivi, a testimonianza delle difficoltà nel seguire adeguatamente i detenuti, portando a un ricorso inevitabile alla somministrazione di psicofarmaci ed esponendo al rischio di dipendenze e di utilizzo improprio dei farmaci rispetto alla loro finalità. A ciò si aggiunga che, in media, ogni 100 detenuti vi è una presenza settimanale di uno psichiatra per 7 ore e di uno psicologo per 19 ore. Significa che in un carcere di medie dimensioni, di circa 300 persone, il medico psichiatra è presente per 21 ore a settimana (3 ore al giorno), mentre lo psicologo per 8 ore al giorno.
- L’emergenza morti in carcere non dà segni di arresto. Anzi, continua a peggiorare. Nel 2024 sono stati almeno 91 i casi di suicidi commessi da persone private della libertà. Tra gennaio e maggio 2025, almeno 33. Il 2024 passa così alla storia come l’anno con più suicidi in carcere di sempre, con un tasso pari a 14,8 casi ogni 10000 persone detenute. Per capire invece la portata del fenomeno, è necessario confrontare tale tasso con quello della società libera. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, nel 2021 il tasso di suicidi in Italia era pari a 0,59 casi ogni 10.000 abitanti. Mettendo in relazione i due dati, vediamo come oggi in carcere ci si tolga la vita ben 25 volte in più rispetto alla società esterna.
Una realtà cruda che necessità di una responsabilità condivisa
Questi numeri ci mettono davanti a una realtà tanto cruda quanto toccante. In particolare i numeri sull’utilizzo di psicofarmaci e sul tasso dei suicidi suscitano una provocazione: in carcere finiscono solo persone fragili da un punto di vista psichico oppure è il sistema carcerario a corrodere molto facilmente la serenità emotiva di chi sta scontando una pena?
Seppur tale questione possa sembrarci distante dal nostro vissuto, un problema di così grandi dimensioni necessita di una responsabilità condivisa di tutta la società, sia anche con pesi e strumenti diversi.
Ripensare il sistema carcerario con riforme di portata strutturale
Alla politica il compito di ripensare il sistema carcerario, immaginando riforme di portata strutturale e abbandonando una logica che ragiona esclusivamente per emergenze, senza progettare scenari migliori sul lungo periodo. Sicuramente a chi governa toccherà riflettere sulla possibilità di incentivare maggiormente il ricorso a misure che non relegano la detenzione all’interno delle mura degli istituti. Se è vero che la nostra costituzione prevede una finalità rieducativa della pena, tale volontà attualmente sembra essere disattesa: diversi studi ci dicono come la percentuale di ricaduta nel reato di chi non abbia lavorato durante la detenzione è pari al 70%, mentre è pari al 2% per chi abbia potuto lavorare all’esterno e pari al 19% per chi abbia svolto misure alternative alla detenzione (ad esempio l’affidamento ai servizi sociali).
A noi cittadini, invece, un’altra responsabilità: quella di non chiudere gli occhi e di non ignorare un fenomeno che, per quanto possa essere distante, coinvolge tutta la società. Informiamoci, parliamo di carcere, sollecitiamo iniziative che provino a portare un pezzetto di mondo esterno all’interno degli istituti. In estrema sintesi facciamo nostro l’interrogativo che Papa Francesco si poneva ogni volta che incontrava un detenuto: “Perché loro e non io?”. Avere compiuto degli errori in passato non può giustificare condizioni detentive che nessuno potrebbe sopportare, non può consentire di togliere lo sguardo da una visione che, per quanto cruenta, ci mette davanti a quanto di più fragile possa esistere.