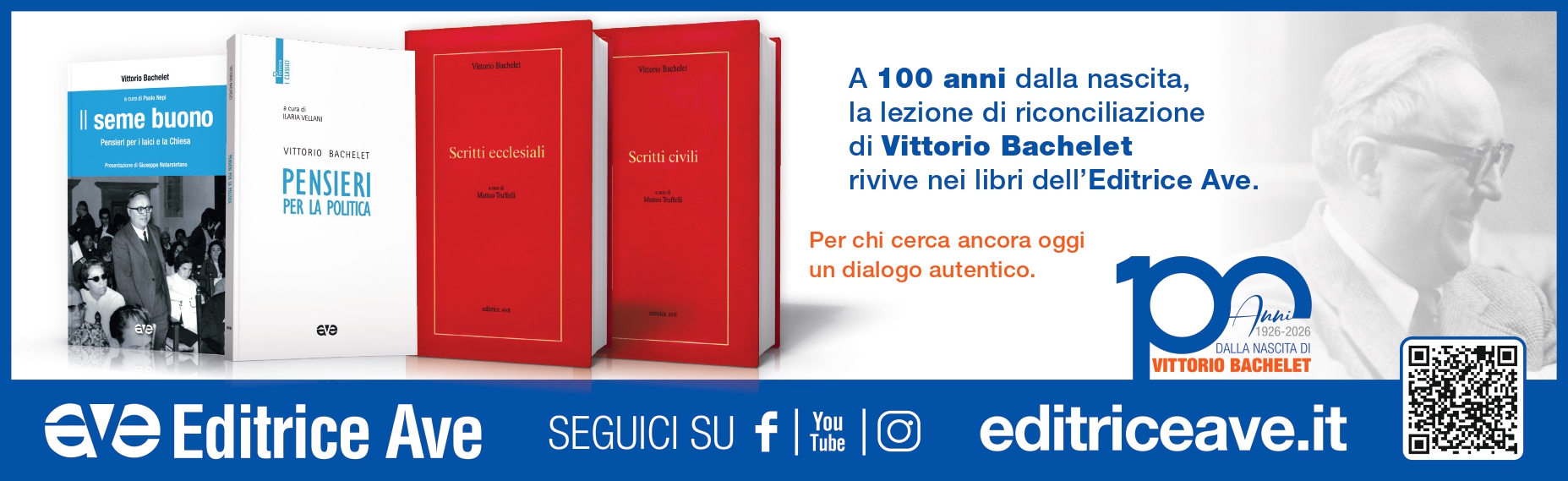La Lettera Uno sguardo diverso, indirizzata al Governo e al Parlamento e sottoscritta dalla maggioranza dei vescovi italiani (tra questi mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Ac, ndr), «frutto di esperienze maturate sul campo» e di un cammino ormai pluriennale (il primo intervento in materia risale infatti al maggio 2019, con la Lettera Mezzanotte del Mezzogiorno indirizzata «agli Amministratori» dai vescovi della Metropolia di Benevento), è motivata da uno «spirito di serena collaborazione», nella speranza che la questione delle “Aree interne” sia ripresa in mano con uno sguardo diverso, appunto, con una progettualità a largo raggio e con tempi adeguati. Per le Aree interne c’è infatti bisogno di una strategia di medio e lungo periodo. Di fronte a tale prospettiva la politica, abituata a cambiare opinione al mutare dei sondaggi, si rivela – allo stato attuale delle cose – incapace.
La pubblicazione del Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne, che per tali aree ha previsto un destino ormai segnato, non ha certo facilitato le cose! Qualcuno potrebbe dire che una verità, amara finché si vuole, è sempre meglio di una pietosa bugia. Ma è vero che le cose stanno proprio così? Le Aree interne presentano solo criticità oppure hanno anch’esse delle frecce nella propria faretra? Prima ancora: è ammissibile che una politica degna di questo nome decida di abbandonare al proprio destino una fetta tanto rappresentativa del Paese? Sarebbe poi una scelta saggia?
La nostra Italia va pensata come un “tutto”
La prima considerazione da fare – nella Lettera Uno sguardo diverso ciò si enuncia con chiarezza – riguarda infatti la connessione tra le parti di questa nostra Italia, che va pensata come un “tutto”, poiché la lenta morte di alcuni territori danneggia l’intero Paese; come infatti nel corpo umano la necrosi di parte del tessuto organico costituisce un danno grave per l’intero organismo, lo stesso avviene quando ci si trova di fronte all’abbandono di una parte del territorio: è la nazione intera a subirne detrimento, perché un territorio non presidiato dall’uomo sarà «sottoposto a una pressione maggiore delle forze della natura, con il rischio» – facile da prevedere – di nuovi e accresciuti «disastri ambientali», e non si potrà evitare la perdita di una parte considerevole di quell’immenso patrimonio artistico-architettonico «che fa dell’Italia intera un museo a cielo aperto».
Ogni paese, ogni borgo (anche il più piccolo, anche di poche case) di questa nostra splendida nazione può vantare infatti un castello, una torre, una chiesa, un piccolo agglomerato degno di nota: si può condannare all’estinzione tutto ciò?
Pure la fuga dalle grandi città è cominciata e crescerà
È vero – e non lo si può negare – che la popolazione attualmente cresce «solo in alcune grandi città e in specifiche località particolarmente attrattive» (Piano strategico, p. 45). È vero però che segnali altrettanto chiari annunciano che pure la fuga dalle grandi città è cominciata (e crescerà sempre più!), perché la qualità della vita che là si respira non è così alta come si vorrebbe far credere, mentre è vero che proprio in quei luoghi in cui la vita rischia di finire essa può invece assumere una qualità superiore: è certo infatti che i giovani che lasciano i loro paesi per i grandi centri, non vanno ad abitare a piazza Navona a Roma o nella zona centrale e più chic di Milano; vanno, essenzialmente, a infoltire l’anonimato delle periferie.
Ho incontrato giovani desiderosi di tornare e d’investire nei territori di nascita le proprie energie e il sapere accumulato fuori, ma impediti a farlo perché quei territori non danno, al momento, prospettive. È su tali questioni che la politica dovrebbe cercare risposte vere, che non si trovano in due giorni. Purtroppo, come dicevo in un’intervista rilasciata al quotidiano Avvenire (13 luglio c.a.), un piano di sviluppo efficace dovrebbe essere, per forza di cose, a lunga scadenza. Ma proprio per questo la questione non si è mai affrontata con serietà: chi governa teme sempre di lasciare i frutti a chi verrà dopo di lui. Come può esserci una strategia in queste condizioni? Per questo, è necessario cambi anche il modo di fare politica.
I vescovi chiedono di «avviare un percorso plurale e condiviso»
Nella Lettera i vescovi firmatari chiedono di «avviare un percorso plurale e condiviso» atto a «generare un ripopolamento delle idee ancor prima di quello demografico». Avanzano inoltre proposte concrete: «s’incoraggi il controesodo con incentivi economici e riduzione delle imposte, soluzioni di smart working e co working, innovazione agricola, turismo sostenibile, valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, piani specifici di trasporto, recupero dei borghi abbandonati, co-housing, estensione della banda larga, servizi sanitari di comunità, telemedicina».
Scambio dei ruoli, con i vescovi che assumono compiti non propri? Non direi. In quanto sentinelle nei singoli territori i vescovi rispondono in tal modo a uno dei loro compiti primari, nella linea della grande Tradizione ecclesiale: si pensi – solo per fare alcuni nomi tra i più illustri – ad Ambrogio di Milano o a Gregorio Magno. Essi, peraltro, sarebbero «lieti di poter esporre» le proprie riflessioni «in un dialogo sereno e costruttivo». Insomma, i vescovi ci sono e vogliono esserci: se anche la politica vuol fare la sua parte, batta un colpo!